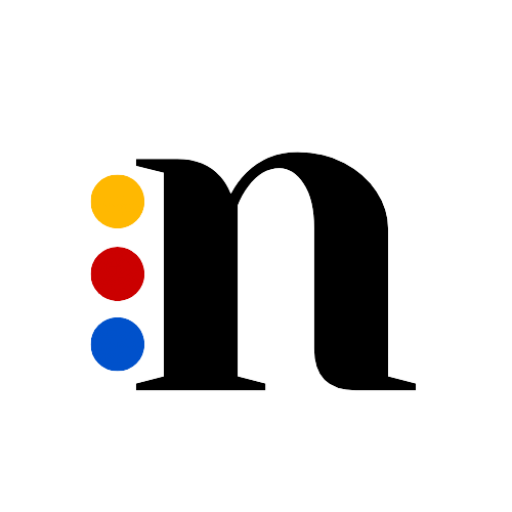Quando la realtà si trasforma in follia, l'arte diventa testimone del proprio tempo. Un racconto sulla guerra attraverso le opere di Goya ed Emilio Notte, che per l'occasione vestono i panni di veri e propri fotoreporter.
«Yo lo vi!», i diari di guerra di Goya ed Emilio Notte
Una riflessione profonda – e quanto mai attuale – sulla caducità della condizione umana e sugli orrori che da sempre, in ogni epoca, ogni guerra porta con sé, è contenuta in nuce nella scena cult del lancio dell’arma-osso in una tra le più celebri pellicole di Stanley Kubrick.
Si potrebbe dire che dal suo lancio, quell’arnese non abbia mai smesso di volare, accompagnando l’uomo nei tempi più bui e offuscando la luce della razón. Quella stessa ragione tanto cara al secolo dei lumi che, nell’offrirsi attraverso le baionette francesi, fece scempio di sé stessa.
Saragozza, 1810-20
Quando non c’era la Leica ad immortalare gli orrori della guerra, si deve al bulino di Francisco Goya la testimonianza di quella realtà che si trasformava lentamente in follia. Ed è proprio Los desastres de la guerra (gli orrori della guerra) il titolo di una serie di incisioni composta da ottanta tavole, realizzata dal maestro madrileno che racconta delle aberranti atrocità a cui può spingersi la bestia uomo.
Questa serie, realizzata tra il 1810 e il 1820, rimase inedita fino al 1863, data della sua pubblicazione. Goya, nelle vesti di fotoreporter, descrive attraverso l’icasticità delle sue incisioni come la guerra faccia venir fuori il peggio della natura umana.
«Yo lo vi!» (io l’ho visto) è forse una delle tavole più celebri di questa raccolta. Tuttavia, non sappiamo cosa effettivamente Goya abbia visto durante il suo viaggio a Saragozza. Che sia immaginazione o eventi riferiti a posteriori poco cambia, lui «l’ha visto» e restituisce la summa visiva di ciò che è parte dell’esperienza collettiva del popolo madrileno. La mano di Goya si muove con pungente realismo attraverso stupri, torture e morte. Le narrazioni di queste tavole si impongono senza dubbio come un crudo reportage.
Napoli, 1941-44
In un rifugio antiaereo di Materdei, Emilio Notte realizza una serie di diciotto fogli intitolato Disegni sotto le bombe (oggi conservati presso il Museo del Novecento di Napoli).
A differenza delle precedenti tavole madrilene, la narrazione in questo caso si esaurisce nell’uso nervoso che Emilio Notte fa della matita grassa: un medium che permette di fare cronaca diretta, attraverso una linea nervosa, sbrigativa, che non ha tempo di perdersi in pretestuosi virtuosismi; passa veloce e traccia l’essenziale, quanto basta per rendere con forza lo stato d’animo dell’artista che si fa rappresentante di chi sta vivendo una tragedia che logora.

Attraverso questo sublime tour-de-force visivo mette in scena il fallimento della civiltà, la condizione di chi vive sottoterra in agonizzante attesa, la stoltezza dell’uomo e della storia in corso.
Ernest Hemingway a proposito del narrare in prima persona afferma che «se lo fai in modo sufficientemente efficace, accade che la persona che sta leggendo finisce col credere che le cose siano successe anche a lei. […] diventerà parte dell’esperienza del lettore e parte dei suoi ricordi»
Gli schizzi di Emilio Notte ci parlano di una realtà di guerra e di tutte le difficoltà che il fotografarla comporta. Non c’è spazio a scelte compositive, tutto scorre, tutto accade sotto gli occhi di chi si limita, con riflessi felini, a restare pronto per catturare l’orrore in atto. Così come in Goya, Emilio Notte si tesse una trama che suggella la memoria collettiva, e che fa da monito e requiem allo stesso tempo della cieca bestialità umana.
Ad oggi, nonostante il monito dei reporter della morte – che da questa hanno saputo estrarre la vita -, la lezione sembra non essere stata elaborata ed assorbita del tutto, e i fatti che riguardano il contemporaneo tendono inesorabilmente alla reiterazione di un già visto cupio dissolvi.