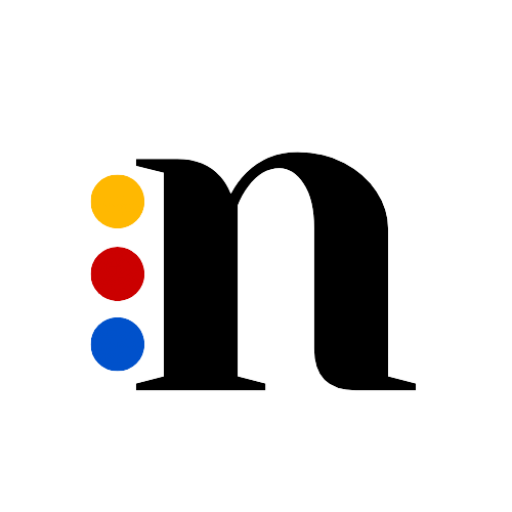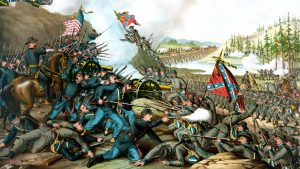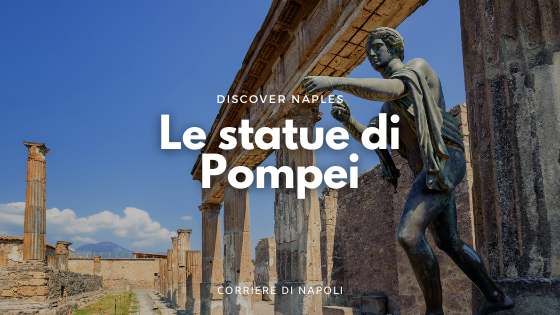
Un nuovo appuntamento con Discover Naples che racconta le bellezze e i misteri partenopei. Pompei e la sua magnificenza sono invidiati in tutto il mondo. Dai mosaici alle ville passando per il cibo sino ad arrivare all’arte e i corpi. Calchi e sculture sono essenze della città vesuviana, sparse tra il Parco Archeologico di Pompei e il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Ma non solo, considerando le mostre itineranti e le eredità nobiliari di resti pompeiani custoditi oggi dai musei di tutto il mondo.
Non solo i mosaici o le grandi architetture ma anche le statue di Pompei sono celebri. Ecco, ma come sono scoperte? Nel 1748 iniziarono gli scavi della città romana più famosa al mondo, dieci anni dopo quelli di Ercolano. L’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. ha raso al suolo la vita partenopea che sopravvive nell’anima e nel ricordo. In particolare al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, che da edificio per la cavalleria borbonica a Università, ha ospitato dal XIX secolo le opere Farnese diventando il polo culturale partenopeo.
I calchi di Pompei
“La più fortunata delle sue invenzioni fu la immagine autentica che diede della catastrofe vesuviana, colando nel masso di cenere che copriva gli scheletri il gesso liquido, per cui questi rivivono nelle forme e nelle contrazioni della loro agonia.”
-Gaetano De Petra
“È impossibile vedere quelle tre sformate figure, e non sentirsi commosso… Sono morti da diciotto secoli, ma sono creature umane che si vedono nella loro agonia. Lì non è arte, non è imitazione; ma sono le loro ossa, le reliquie della loro carne e de’ loro panni mescolati col gesso: è il dolore della morte che riacquista corpo e figura…. Finora si è scoverto templi, case ed altri oggetti che interessano la curiosità delle persone colte, degli artisti e degli archeologi; ma ora tu, o mio Fiorelli, hai scoverto il dolore umano, e chiunque è uomo lo sente”.
-Luigi Settembrini
Tra le prime forme di ritrovamenti a Pompei sono state quelle dei corpi. Nel corso degli scavi di Pompei sono stati rinvenuti i resti di oltre mille vittime dell’eruzione del 79 d.C. Tra le prime testimonianze della civiltà romana ci sono delle vere e proprie opere d’arte, ovvero i calchi. La celebre invenzione di Giuseppe Fiorelli permise, e permette ancora tutto oggi, di estrarre i corpi dagli ambienti invasi da pomici e lapilli o furono investiti dai crolli provocati dal materiale eruttivo depositatosi fino a un’altezza di circa tre metri.
Una tecnica particolare che dal XIX secolo ad oggi ha permesso di comprendere realmente come vivevano i romani. Basti pensare che proprio attraverso un calco che indossava una sciarpa oppure i frutti autunnali ritrovati hanno permesso di comprendere come l’eruzione del Vesuvio non avvenne ad agosto bensì a novembre. Dall‘Orto dei Fuggiaschi alla letteratura, i calchi delle vittime, esposti in vetrine di metallo e vetro, furono molto ammirati già nel primo “Museo Pompeiano”, allestito da Fiorelli nel 1873-1874. I numerosi calchi realizzati nel corso del Novecento sono invece generalmente lasciati a vista sul luogo del rinvenimento, in vetrine o protetti da tettoie.
L’idea di Fiorelli è proseguita nel corso del XX secolo non solo a Pompei e non solo con gli esseri umani. Ma quali sono i processi per i calchi? In soccorso giunge proprio la spiegazione fornita sul sito del Parco Archeologico:
È in questa cenere indurita che spesso gli archeologi rinvengono dei vuoti, causati dalla decomposizione di sostanze organiche: può trattarsi di elementi in legno come mobili, infissi, oggetti ma anche di corpi degli individui.
Nel vuoto viene quindi versata una miscela di gesso ed acqua fino a riempirlo totalmente.Lasciato asciugare il gesso, si può procedere nello scavo e si mette in luce ciò che aveva determinato il vuoto: la cenere indurita ha conservato infatti, come uno stampo, il volume, la forma e la posizione dell’oggetto o del corpo che era stato sepolto. Questa impronta di gesso solidificato è chiamato calco.
Le statue di Pompei al MANN
Ma come sono state scoperte le statue di Pompei? Nel corso del secolo della ragione, il ‘700, Carlo Di Borbone promosse l’avvio degli scavi nelle zone vesuviane. Secondo alcune leggende metropolitane, il duca d’Elboeuf, quando si fece costruire la Villa verso Portici, cominciò a fare delle donazioni in giro per il mondo.
Pare infatti che al momento della scoperta di resti nei pressi del luogo della costruzione, ci fu il rinvenimento di alcune statue che furono consegnate anche alla cugina della Regina Maria Amalia di Sassonia. Una scoperta che diede il via agli scavi da parte dei Borbone interessati da queste scoperte.
Secondo altri fonti storiche, la costruzione del ponte da parte del Conte di Sarno per opera di Domenico Fontana portò al rinvenimento di alcune sculture e vasi che lasciarono pensare al ritrovamento di una civiltà. Peccato che gli scavi non continuarono e si aspettarono altri 100 anni per promuovere gli studi che poi proseguirono con la nascita dei Musei di Portici ed Ercolano e l’Accademia Ercolanese.
Insomma varie sono le ipotesi a proposito del ritrovamento delle statue romane che oggi sono custodite al MANN ma non solo, come la scultura dell’Abbondanza. Tante le statue sparse il mondo, non solo di Pompei. La grande stagione degli scavi coinvolsero anche altre zone in giro per l’Italia come a Tivoli nella Villa Adriana per la nascita delle ville rinascimentali.
Un patrimonio inestimabile che oggi sarebbe potuto essere ancor più ricco considerando i tanti furti degli ultimi anni oppure la gestione errata senza un criterio archeologico particolare. Un rispetto culturale migliorato solo nel tempo che oggi ci ha restituito l’essenza pompeiana.
Potrebbe interessarti: