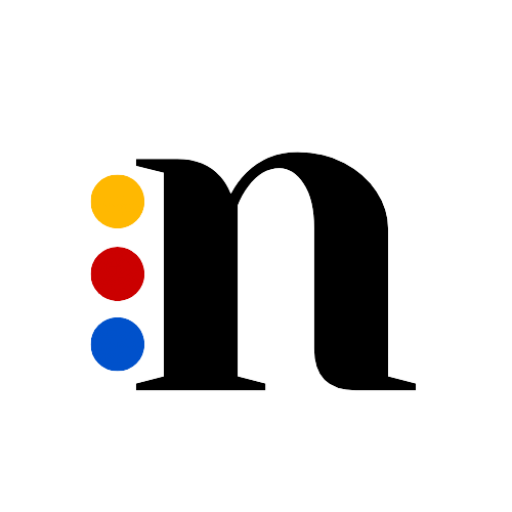Da soggetto a medium espressivo: una passeggiata tra la macelleria di Joachim Beuckelaer e le Wedding Souvenir di Claes Oldenburg mostra come ed in che modo la pratica artistica si relaziona e dialoga con il cibo.
Arte e cibo tra Joachim Beuckelaer e Claes Oldenburg
Due figure si stagliano su due tavole distinte. Il loro incarnato, di un pallore alabastrino, fa da pedant al fondo scuro. Su di un suolo sassoso, Eva, con disinvolta sicurezza afferra il celebre malum, infrangendo il sacro divieto che provocherà la rottura dell’accordo tra Dio e l’uomo: si tratta dell’«atto alimentare» (Silvia Malaguzzi) più iconico della Genesi (Dürer, Adamo ed Eva, 1507), e la pittura – che per secoli della religione ne ha fatto la sua primadonna – questo lo sa bene.

Un secolo e mezzo dopo la realizzazione di Adamo ed Eva, nel Convito di Assalone (1668) di Mattia Preti – oggi custodito presso il Museo di Capodimonte – una tovaglia candida accoglie svariate pietanze che, assieme al prezioso vasellame posto in penombra, assistono al consumarsi di una brutale esecuzione. Si tratta di oggetti che fanno da contesto allo svolgersi della scena principale, ma che in qualche modo testimoniano il registro aristocratico dell’iconografia e della committenza.
Tuttavia, una situazione del tutto opposta la si ritrova facendo compere nella Bottega del macellaio (1568) di Joachim Beuckelaer. Questa volta, le persone indaffarate nelle loro attività diventano fondalino, facendo si che i riflettori vengano puntati dritti sulla mercanzia: i cadaveri squartati degli animali. Una scena che si fa erotica nella misura in cui il consumo estetico si corrompe di criteri anti-manieristici, provocando un ricercato e crudo realismo.
In una tematica che vede la sua fortuna verso la metà del Cinquecento, Beuckelaer mescola natura morta e scene di vita quotidiana, intersecando diversi livelli di lettura – come ad esempio l’allusione al tema della vanitas.
Si tratta di un genere pittorico che pone l’accento sui valori legati alla merce, al lavoro di produzione e al materialismo determinato dal commercio e dallo scambio. Non a caso Joachim Beuckelaer proviene da uno dei centri fondamentali per l’economia del vecchio continente: le Fiandre.

In qualche modo, questa propensione alla poetica dell’oggetto anticipa – con le dovute differenziazioni storiche – la fame consumistica che, verso la metà degli anni Sessanta del secolo scorso, cambia drasticamente la qualità della vita quotidiana.
Con la Pop Art si pone l’attenzione sulle nuove immagini, sulle icone e sugli oggetti popolari, riconoscendone un valore positivo – in quanto elementi fondamentali del nostro panorama urbano riscattandoli attraverso lo «straniamento» (Barilli) di oggetti banali.
La carne dalla Bottega del macellaio viene ora trattata, cucinata ed impacchettata per essere venduta alle grandi masse. In 200 Campbell’s Soup Cans (1962) di Warhol, la celebre lattina di zuppa è inserita in uno schema paratattico che nulla rivendica del prodotto inscatolato: la ripetizione seriale si fa horror vacui, ricalcando con fare provocatorio le strategie di marketing volte allo stravolgimento del prodotto contenuto. È il tripudio del packaging, del bombardamento mediatico, della pubblicità e del consumo.

Un altro palato fine della Pop Art è sicuramente Claes Oldenburg, che riproduce cibi e oggetti quotidiani deformandoli, modificandone dimensioni e consistenza. Ironia della sorte, l’artista svedese nasce nel lontano 1929: una data che si pone come un tragico fotogramma in negativo rispetto al contesto sociale che fa da cornice – o forse sarebbe più opportuno dire da piatto – alle sue opere.
La poetica dell’oggetto-merce di Oldenburg, infatti, si inserisce in un discorso improntato sulla critica del circuito dei grandi boom economici e dell’espansione della produzione di massa. È questo il milieu in cui realizza Wedding Souvenir (1966): fette di torta che si fondono tra naturale ed artificiale, sublimandosi in un mimetismo illusorio di richiamo duchampiano.

In pieno stile oldenburghiano infatti, i dolci che si offrono gustosi agli occhi di chi ne fruisce, risultano invece essere stati realizzati in una poco appetitosa colata di gesso, rendendone difficoltoso un ipotetico processo digestivo. Ironia ed inquietudine si mescolano in vista di un realismo che si contraddice nel trattamento assurdo dei materiali.
Negli anni Novanta un altro artista trasforma il cibo in esperienza estetica: si tratta del caso Rirkrit Tiravanija. Formatasi nell’humus degli happenings, la pratica artistica di Tiravanija si lega indissolubilmente all’«arte relazionale».
L’artista thailandese infatti crea dei veri e propri «interstizi» (Bourriaud) relazionali all’interno di istituzioni museali o gallerie private, di cui il cibo ne è il medium: l’artista installa fornelli, tavole e cucina piatti tradizionali. Il visitatore diventa – mangiando, cucinando ed interagendo con gli altri – parte attiva in un processo in cui l’atto creativo non genera manufatti ma esperienze e legami.
Con la decima puntata di questa rubrica, Pathosformel: l’Atlante Farnese si conclude tra peccati di gola e torte in gesso, nella speranza che la lettura di questi brevi spunti possa aver innescato curiosità e fame d’approfondimenti nel lettore.