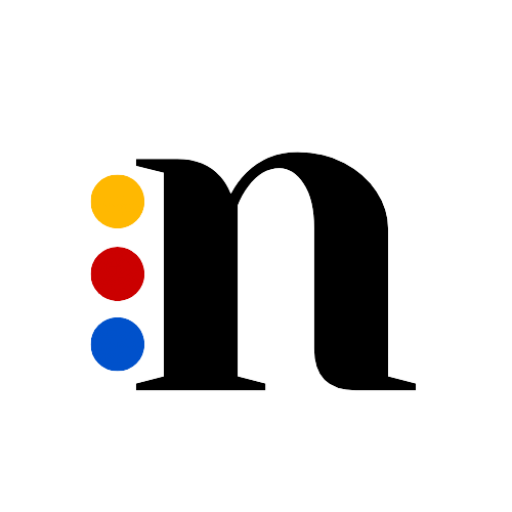Cosa hanno in comune un mezzobusto in cera rappresentate una donna, una serie fotografica intitolata “The Morgue” e dei bozzetti preparatori per la celebre “Zattera della Medusa"? In un immondo carnevale di ripugnanza la morte si fa mezzo espressivo.
Vanitas vanitatum: la morte come linguaggio artistico
La caducità e la morte si fondono insieme negli occhi socchiusi di una figura femminile in decomposizione, mentre i vermi si fanno spazio tra le interiora fino a sfondare verso l’esterno di quella pelle giallognola, che si offre come un rivoltante spettacolo macabro alla vista dello spettatore.
Un volto – un tempo bellissimo – si scioglie inesorabilmente sotto i segni della morte. Si tratta della “Vanitas” di Capodimonte: un mezzobusto di donna modellato con una minuziosa ricerca anatomica, che incute nello spettatore una dolce e curiosa attrazione-repulsione.
Tra terribili epidemie e la guerra dei Trent’anni, la morte (diventata fatto quotidiano) non può che diventare uno dei temi privilegiati nell’immaginario degli artisti. La cera, datata tra l’ultimo quarto del XVII e gli inizi del XVIII secolo e realizzata da un artista ignoto, affronta infatti quella che per il tempo fu una vexata quaestio.
L’inquietante memento mori della tradizione barocca, è la rappresentazione della morte che nella sua immonda e ripugnante essenza si fa estetica del cadavere, sublimandosi in una disgustosa contemplazione. È indubbio che il clima della controriforma caratterizzi questo tipo di soluzioni estetiche in cui la commovente scena svolge anche funzione catartica, invitando a pensare alla caducità del corpo in contrapposizione all’immortalità dell’anima.
Numerose sono le opere che ritornano alla mente guardando la struggente ceroplastica in questione. Per i temi trattati – penitenza corporale e caducità della vita – il riscontro più interessante è forse quello che si ha con la Maddalena penitente di Jusepe Ribera. Anche se ritorna, nel gesto della testa reclinata con la bocca spalancata, un’espressività estatica tipica delle sante berniniane.

La Vanitas di Andres Serrano
Tuttavia, il confronto che vorrei sottoporre oggi all’attenzione del lettore, riguarda una serie fotografica del 1992. Si potrebbe dire che stessa “estetica del cadavere” che si offriva nella Vanitas di Capodimonte che ritroviamo – violenta più che mai- salendo sul battello di Harry Morgan in cui «nel pozzetto le facce gonfie dei morti luccicavano sotto la luce, laccate di marrone dove il sangue si era asciugato» (“Avere e non avere”, Hernest Hemingway), caratterizzi la serie “The Morgue”,di Andres Serrano.
Serrano veste i panni del dottor Tulp, entrando in un obitorio e iniziando a scattare primi piani di persone morte, con i volti coperti in parte per nasconderne l’identità. Il fotografo riesce a creare un autentico reportage su una tematica cruda che accomuna noi tutti, rappresentando l’irrappresentabile con un taglio che induce il fruitore ad assumere un atteggiamento voeyurista.
Quello che in un primo momento potrebbe sembrare un approccio quasi poliziesco per l’eccessivo realismo, in realtà è il trionfo della suggestione estetica ed emotiva, in cui il dettaglio perturbante diventa protagonista. La frammentazione delle inquadrature ostruisce qualsiasi lettura narrativa: il dettaglio non è mezzo per l’informazione, ma espediente estetico.

Lo stile degli scatti di serrano si pone in antitesi rispetto ai soggetti rappresentati. La violenza, la tumefazione e la morte si dispongono in composizioni potentemente icastiche, in cui tutto è prima di tutto armonia. Non c’è trama, non è la storia dei singoli individui, ma trasformazione del corpo umano che diventa «un pezzo di mondo, una cosa tra le cose, in una perfetta soluzione di continuità con la materia del mondo, fredda e inanimata, inerme e non più semovente» (Claudio Bonvecchio).
Il cadavere diventa oggetto estetico, che si dilata in uno spazio privo degli accidenti aristotelici. L’obitorio è presente infatti soltanto nel titolo, risultando assente come contesto spaziale.
L’obbiettivo di Serrano ha gli attributi che caratterizzano il pennello dei maestri della pittura. I suoi soggetti emergono dalle tenebre dello sfondo con un’impostazione direi classica. La cruda rappresentazione della progressiva decomposizione che appare sulle carni, il mutamento di tonalità, i tessuti imbevuti di liquidi giallognoli fanno da pendant ai celebri dipinti che Géricault decise di realizzare studiando i suoi soggetti dal vero.

Serrano, inoltre, attinge all’iconologia cristologica, mostrando ferite e segni analoghi alle stigmate dei santi. Le immagini si costellano di cristi laici che, con atteggiamento goyesco, parlano di un’unica morte: quella fisica, quella di una realtà che non è eterna e che la storia dimentica. In queste immagini infatti non c’è spazio per la memoria, ma è proprio questa damnatio che porta il soggetto in una dimensione simbolica. È l’idea della morte che – nonostante l’attenzione per il dettaglio che rivela peli impastati nel sangue rappreso, pelle in decomposizione, carne arrossata cicatrici post autopsia – nella sua rappresentazione ideale è protagonista assoluta, a discapito della materialità dei corpi, dei cadaveri.
L’entrata in scena del simbolico induce nello spettatore – alla stregua di quanto accadeva nelle opere rinascimentali e barocche – una riflessione sulla morte, sul carattere effimero della vita e sulla finitudine umana.
Ecco che quindi, fatte le dovute contestualizzazioni, dalla fotografia al pennello, cambia il medium, ma la logica che muove i meccanismi della Vanitas di Capodimonte e quella di Serrano rimane in parte la stessa.