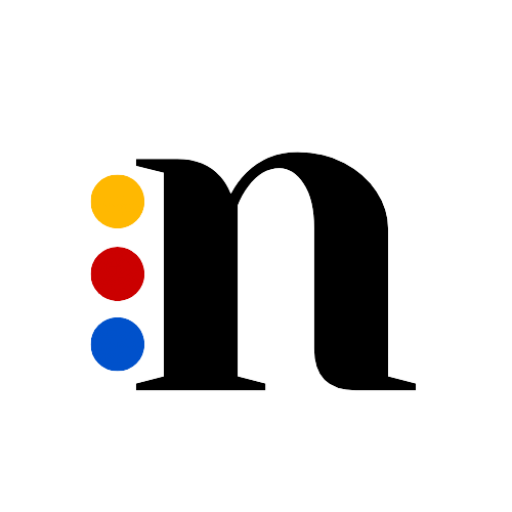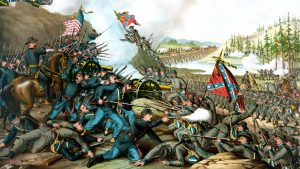L’Atlante di Piero Manzoni si compone di un facile sillogismo: tutto ciò che fa l’artista è arte, e in questo senso il mondo diventa scultura.
L’Atlante di Piero Manzoni
Un uomo barbuto dalla folta capigliatura ci mostra uno sguardo severo e, al contempo, comunica forza reggendo un globo imponente. Si tratta dell’Atlante Farnese: opera in marmo bianco a grana fine datato all’età Antonina, conservato presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Rinvenuto nelle terme di Caracalla a Roma intorno al 1546, la scultura ellenistica è oggi visibile nel Salone della Meridiana, e rappresenta il titano come metafora di resistenza intesa come sopportazione.
Esiodo racconta che, durante la Titanomachia, Atlante si era alleato con Crono e aveva guidato la rivolta dei titani contro gli dèi dell’Olimpo. In conseguenza al grave affronto, Zeus decise di punirlo costringendolo a tenere sulle spalle l’intera volta celeste.

Facendo ora un piccolo salto temporale: nel XX secolo ci si ritrova in un contesto artistico che risulta essere quasi diametralmente opposto alla classicità che permea la scultura in questione. Infatti, di fondamentale importanza è la disfatta della plurisecolare prospettiva geometrica, che porta consequenzialmente gli artisti ad esplorare le caratteristiche fisiche degli spazi in cui agisce la dimensione corporea. Si assiste quindi allo spazio dell’opera che si fa spazio dell’azione.
In concomitanza con la rottura operata dai movimenti d’avanguardia, si riscontra l’esigenza di cercare una relazione più diretta tra opera e ambiente da parte degli artisti. L’espansione delle manifestazioni artistiche nello spazio portano il discorso delle belle arti nella dimensione delle arti plastiche. Questi cambiamenti si realizzano, in prima battuta, andando a lavorare sui limiti imposti dalla cornice e dal piedistallo.
Ecco che Rodin prima – nel 1899 con Eva che presenta i piedi direttamente poggiati sul suolo – e Brancusi poi – che ingloba il piedistallo nel discorso estetico – viene messa in discussione la funzione basamento.
Quando il Ceci n’est pas une pipe si fa vera pipa – tangible – le cornici e i piedistalli non hanno più ragione d’esistere in rappresentazioni che deflagrano nella sfera del reale
Tuttavia, un’artista eccentrico come Piero Manzoni risulta essere l’eccezione che conferma la regola. Nel 1961, espose in Danimarca quello che si può intendere – iconologicamente parlando – come un equivalente suggestivo dell’Atlante Farnese. Ovviamente questa familiarità non deriva da una dimostrazione – nel senso di come si potrebbe intendere nell’iconologia una ricerca del significato ultimo – ma proprio dal funzionamento logico dell’immagine.
Venendo al sodo, l’Atlante di Piero Manzoni consiste in un parallelepipedo nella cui iscrizione capovolta si legge «Socle du monde, socle magique n. 3, de Piero Manzoni, 1961, Hommage a Galileo». Lo stesso Galileo che, come dirà l’artista, ha insegnato all’uomo come «vedere» in modo diverso, da angolature differenti.
E se l’Atlante Farnese offre il capovolgimento della sfera celeste poiché idealmente vista dall’esterno – aspetto inusuale rispetto alle raffigurazioni tradizionale di matrice geocentrica – Manzoni estremizza l’operazione ribaltandone la struttura iconologica trasformando il mondo stesso in scultura
Germano Celant scrive che «l’arte crea uno spazio ambientale nella stessa misura in cui l’ambiente crea l’arte». Così come l’Atlante è rappresentato nell’atto di sorreggere il globo, allo stesso modo ciò che la base magica sostiene è il mondo intero.
Piero Manzoni è un profanatore, artista della mercificazione, e quest’opera – come tante altre – si struttura su di un facile sillogismo: tutto ciò che fa l’artista è arte. La cometa Manzoni sfiora il concettuale, richiedendo allo spettatore una buona dose di integrazione immaginativa – così come nel caso delle linee (1959-63) -, assorbendo e superando magistralmente il gesto duchampiano in una poetica costellata di paradossi fruibili unicamente per vie concettuali, ma che si restituiscono in un appagante risultato estetico.
Con il primo articolo di questa nuova rubrica si vuole quindi introdurre come la familiarità di forme va colta nella loro filogenesi, ma anche nella loro differenza storica, permettendo un diverso modo di sentire e connettere gli elementi tra loro nell’economia di un discorso più ampio.