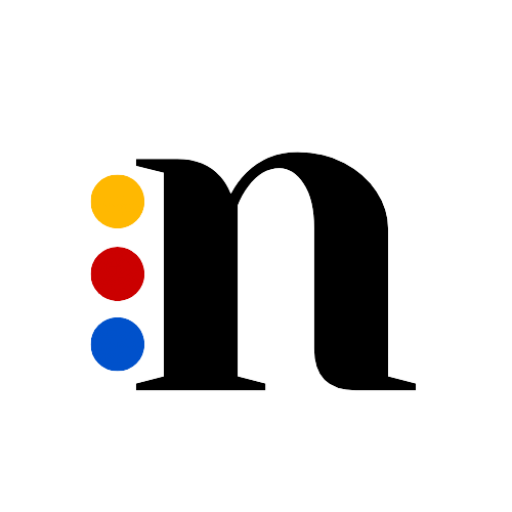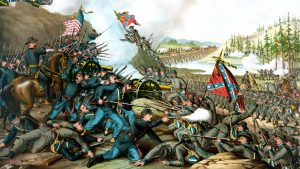Agli inizi del Novecento, nella Napoli della Belle Époque, il teatro resiste al cinematografo e Eduardo Scarpetta ne è il re.
Sul Finire dell’Ottocento, in realtà, Napoli perde il ruolo di città-capitale facendo emergere la miserabile vita di un popolo sul limen tra antichità e modernità.
Sebbene il capitalismo industriale non fosse la strada prediletta da un popolo amante del dolce clima e della magnanimità di sovrani e signori, la nuova Napoli riesce a trovare volto e voce nella figura di Felice Sciosciammocca: la maschera senza maschera di un piccolo borghese illetterato che sta lì a guardare il mondo a bocca aperta.
Eduardo Scarpetta, napoletanizzando il repertorio francese della pochade e del vaudeville, riesce a “resuscitare” il teatro popolare sostituendo con il suo Sciosciammocca, l’amata nera maschera del Pulcinella di Petito, suo maestro.
Si sentiva il bisogno di ridere da parte di un pubblico stanco di vedere maschere miserabili che “campano la giornata” costrette a reinventarsi quotidianamente per sopravvivere, preferendo attori ben vestiti specchio di una medio-borghesia che si fa sempre più strada nel tessuto sociale e soprattutto economico partenopeo con tutte le sue risibili contraddizioni.
Scarpetta-De Filippo: storia di una “tribù”
Già dalle prime inquadrature di Qui Rido Io, pellicola di Mario Martone presentata a Venezia 78 e in sala dal 9 Settembre, si percepisce la volontà del regista napoletano di rendere omaggio a Napoli e ad uno dei suoi più grandi protagonisti: Eduardo Scarpetta (Toni Servillo), facendolo conoscere non solo come grande attore e commediografo, ma anche come uomo, pater familias, descrivendo i complessi e dolorosi legami del suo nucleo familiare.
Tutti gli appartenenti alla tribù degli Scarpetta sembra che vivano in funzione di Eduardo. Una presenza ingombrante e carismatica, perno del fragile equilibrio di una singolare famiglia composta da mogli, madri, amanti, figli legittimi e illegittimi dove regna l’ipocrisia e l’amoralità.
Il controverso legame con i figli è proprio uno dei temi attorno al quale ruota lo spaccato di vita ripreso da Martone e che ha il suo exploit nella scena delle prove di Miseria e Nobiltà: sul palcoscenico viene messo in scena il dramma di un’intera famiglia e di una paternità negata ai figli e a se stesso.
In poche inquadrature il regista fa percepire allo spettatore il dolore di figli che non conoscono l’amore per il sangue, ma solo quello per il teatro, per il palco, il quale diventerà la loro più grande eredità.
Il teatro diventa l’unico legame della tribù. Un legame più forte di quello del sangue, un passaggio di testimone verso la libertà, come dirà il giovanissimo Eduardo De Filippo (Alessandro Manna) al fratello Peppino (Salvatore Battista).
Un passaggio rituale ostacolato per chi come il figlio Vincenzo (Eduardo Scarpetta) resta lì dietro le quinte in attesa del suo turno, del suo tempo. Un tempo doloroso per il padre che vede il tempo della commedia finire e per il figlio che immagina per sé un palcoscenico diverso.
Il Figlio di Iorio e il D’annunzio parodiato
Qui rido io non è solo il titolo del film di Martone, ma è anche la frase che Scarpetta fece incidere sulla facciata della sua residenza La Santarella, in via Luigia Sanfelice al Vomero, un luogo di pace per il capocomico, un luogo dove ridere tanto del vecchio Pulcinella, quanto del vate D’annunzio e della schiera di giovani artisti e letterati napoletani che lo accusavano di aver tradito il teatro popolare.
Al grido di «Basta!», «Abbasso i contraffattori! Abbasso Scarpetta!» «Viva Gabriele D’annunzio! Viva l’arte italiana!» durante la rappresentazione de Il Figlio di Iorio al teatro Mercadante ha inizio la querelle linguistico-culturale che porterà Scarpetta in tribunale contro il Vate.
Il 2 marzo 1904 va in scena al teatro Lirico di Milano l’opera di D’annunzio (Paolo Pierobon) La Figlia di Iorio, dalla quale Scarpetta non fa altro che trarne una parodia chiedendone al Vate i diritti. Diritti che l’autore desiste dal dare deridendolo.
L’aspetto più interessante che emerge dalla pellicola di Martone, è la formazione e lo schieramento di partiti di letterati, poeti e commediografi dell’epoca, primi fra tutti Salvatore di Giacomo (Roberto De Francesco), a difesa del pescarese, e Benedetto Croce (Lino Musella) schierato dalla parte di Scarpetta.
Il palco del tribunale diventa per Eduardo un momento di teatro. Mentre difende la sua opera parodia, la sua arte, facendo sì che la causa per plagio diventi solo un pretesto per un discorso più ampio sul concetto di arte, ma i giovani drammaturghi falliranno nella loro messa in discussione della carriera del vecchio commediante, perché come disse lo stesso amico Bracco durante il processo:
la parodia è arte perché è nella vita: accanto all’infinitamente grande vi è l’infinitamente piccolo. Non a caso qualcuno ha definito il ridicolo come il sublime a rovescio. Ed è ovvio quindi che delle opere più in voga, dei capolavori, in ogni tempo, si sia sempre fatta la parodia. Sotto questo aspetto la parodia è un tributo all’autore, non un’ingiuria.
Questa sequenza ha anche il merito di alludere allo stesso Martone, che come Bracco, venne chiamato a testimoniare nel processo contro Totò che visse due volte di Ciprì e Macario.
In quella sede, il regista, difese l’arte libera, scomoda e oscena capace di rendere i propri creatori eterni ed immortali anche quando arriva il tempo per loro di calare il sipario e lasciare il posto ai nuovi maestri.