
Benvenuti nella prima puntata di “Riscopriamo Napoli”, una rubrica nata per approfondire gli aspetti storici e culturali più insoliti, meno noti o curiosi della città. Il nostro viaggio comincia nel Rinascimento napoletano, uno stile che non ebbe proprio quella risonanza come era capitata alle altre grandi sorelle italiane quali Firenze o Roma.
L’arte napoletana rimane profondamente legata al barocco napoletano che affonda le sue radici nel periodo in cui Napoli era un viceregno alle dipendenze della corte di Madrid. Grazie all’influsso dei vicerè, dei nobili e della classe ecclesiastica, l’arte barocca rivoluzionò il volto di Napoli dalla pittura all’architettura.

Ma l’arte napoletana non è interamente costruita solo sul barocco. Tra i vicoli stretti e le strade affollate, nelle chiese e nelle piccole e grandi piazze è possibile scorgere le testimonianze artistiche di altri tempi e collegate ad altre correnti artistiche. A piazza Monteoliveto, nel cuore del centro storico, è sita la Chiesa di Sant’Anna dei Lombardi (nota in precedenza con il nome di Santa Maria di Monteoliveto), all’interno della quale è possibile ammirare la fantasia di colori e simboli religiosi e laici che compongono la sagrestia del Vasari, vero e proprio isolotto rinascimentale bagnato da un oceano barocco.
Giorgio Vasari ed il Manierismo

La sagrestia prende il nome dal fondatore del Manierismo, Giorgio Vasari. Nato ad Arezzo nel 1511, nonostante la sua formazione artistica (tra i suoi maestri si annovera Michelangelo Buonarotti) Vasari è ricordato più come un teorico per le sue Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, con la quale pone le basi della corrente manierista.
I lavori svolti a Roma nel 1544 gli fecero acquisire una buona popolarità al punto da ricevere molte committenze da Napoli. Vasari vi ci trasferì per un biennio (1544/1545) e questo lo fa uno dei pochi artisti che esportò il Rinascimento nella città napoletana.
Durante il soggiorno napoletano incontrò Gian Matteo d’Aversa, abate Generale della Chiesa di Santa Maria Monteoliveto, che gli affidò l’incarico di affrescare il refettorio (l’attuale sagrestia). “Ricordo come adi 20 di Novembre 1544 il medesimo Abate Generale di Monte Oliveto di Napoli mi alloga a farvi nel Convento di detto Monastero il Refettorio dove anno a mangiare i Frati”.
Inizialmente Vasari, una volta preso visione della struttura da affrescare, decise di declinare l’offerta a causa del fatto che il refettorio era fatto “d’architettura antica”, cioè era gotica, non disponeva di un’adeguata illuminazione che esaltasse la sua opera e soprattutto dichiarò anche che ne “avrebbe ad acquistarvi poco honore”. Miniato Pitti, un religioso amico del pittore, lo convinse alla fine ad accettare il lavoro, ma ad una condizione, cioè eliminare quello che per lui corrispondeva ai canoni del gotico per rimpiazzarli con i suoi ideali di arte dal sapore manierista. Insomma, quello che doveva essere un semplice affresco del soffitto si trasformerà in vero e proprio restyling che modificò gli interni della sala e che si concluse nel 1545.
La Sacrestia del Vasari

Entrando nella sagrestia, la prima cosa che l’osservatore può notare sono gli splendidi affreschi che decorano la volta che viene suddivisa in tre sezioni iconografiche centrali rappresentate dalle figure della Fede, Religione ed Eternità. Ognuno di questi quadranti è circondato dalle virtù che sembrano rispondere ad un preciso schema messo a punto da Vasari.
Come ha osservato Pierluigi Leone De Castris, possiamo notare che la Fede sembra collegarsi alle figure della Penitenza- Preghiera, della Castità, Speranza in Dio ecc. che rimandano al concetto stesso di fede. Così pure nella sezione dell’Eternità troviamo virtù che rimandano alla vita monastica come Fortezza, Giustizia, Prodigalità, Studio, Sapienza ecc. Infine, l’ultimo quadrante della Religione presenta le virtù legate al movimento olivetano della Bontà, Concordia, Silenzio ecc.

La Sagrestia coniuga anche gli elementi religiosi con quelli laici. Ai lati dell’ingresso è possibile scorgere l’Ursa maior e l’Ursa minor (raffigurati come orsi), mentre sono sparsi lungo il soffitto i segni zodiacali. Inserire questi rimandi all’astrologia ed all’astronomia fu di certo una scelta molto coraggiosa viste le circostanze del periodo. Vasari fu chiamato ad affrescare l’ex refettorio proprio nel periodo della Controriforma durante la quale la Chiesa cercò di riaffermare i propri principi per contrastare l’ondata protestante che stava dilagando in Europa.
La curia papale fissò un occhio di riguardo sulle arti figurative affinché esse potessero ubbidire ai nuovi dogmi imposti. In sostanza, Vasari ha corso un grosso rischio dipingendo delle figure che per la mentalità dell’epoca era un rimando alla cultura pagana, per di più in una struttura adibita al culto della cristianità.
Spostando l’attenzione verso il basso è possibile trovare le tarsie realizzate dal frate Giovanni da Verona tra il 1505 ed il 1510. Inizialmente questi intagli erano allocati nelle aree all’infuori della sagrestia. Successivamente i tarsi furono trasferiti nell’ex-refettorio tra il 1558 ed il 1668, quando la vecchia sala mensa della chiesa venne convertita nella sagrestia. Questi tarsi raffigurano strumenti che rimandano alla vita monastica, nonché animali simbolici e vedute della città di Napoli. Ad intervalli regolari, infine, è possibile intravedere nelle nicchie delle statue lignee dei santi olivetani.
Fonti: Ricordo n. 145 del 1544-11-07 (Archivio Vasari)
Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, p. 992
Per altri dettagli, si rimanda al bollettino rilasciato da PierLuigi Leone De Castris
Potrebbe interessarti:
L’incendio e il falso storico di Santa Chiara
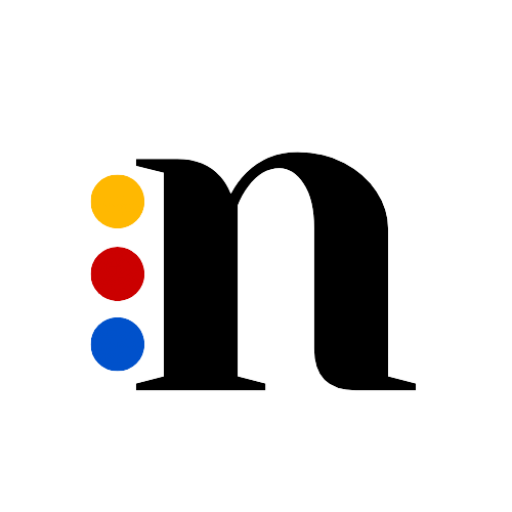


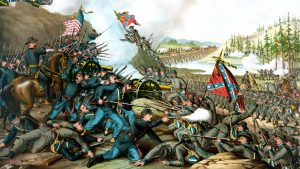

1 thought on “La sagrestia Vasari: una piccola perla rinascimentale”
Comments are closed.